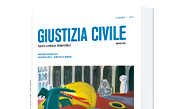1. Lo spunto per questo breve editoriale è l'ultima evoluzione di un corposo contenzioso in materia di assorbibilità dei superminimi e, in particolare, l'esito dei primi pronunciamenti della Suprema Corte (sei ordinanze, emesse dal medesimo collegio, che accolgono i ricorsi dei lavoratori e rigettano quelli del datore di lavoro).
2. Anticipo subito di essere consapevole che, in qualità di legale di una delle parti coinvolte, non è mio compito entrare pubblicamente sul merito della questione e, in effetti, con questo breve editoriale non è assolutamente mia intenzione farlo. Senonché, dopo aver apertamente segnalato al lettore il mio ruolo nella vicenda, e senza delegare a terzi, mi limito ad evidenziare ciò che davvero mi ha sorpreso dopo essermi a lungo occupato dei temi della prevedibilità del diritto e dei rischi di un eccessivo soggettivismo giudiziale.
3. Come si vedrà, si tratta di alcune ordinanze della Suprema Corte che, in materia di usi aziendali, dopo aver declinato l'istanza di discussione in udienza pubblica, affermano principi innovativi rispetto ad alcuni precedenti della medesima Corte. Precedenti che in alcuni casi risultano emessi da collegi composti in modo prevalentemente coincidente. È vero che ogni pronuncia resta condizionata dal caso concreto che decide, ma i principi di diritto restano e questo caso, a parere di chi scrive, merita di essere segnalato.
4. La questione del contendere, in estrema sintesi, ha ad oggetto l'avvenuto assorbimento dei superminimi, concessi con espressa indicazione della loro assorbibilità, da parte di un datore di lavoro che, a fronte di precedenti rinnovi del CCNL, non aveva azionato l'assorbimento. Tra le varie questioni da considerare c'era anche quella dell'esistenza di un uso aziendale che vincolava il datore di lavoro a non assorbire e la Cassazione, proprio su questo punto, accoglie il ricorso dei lavoratori (Cass., 11 maggio 2025 n. 12477 e n. 12473; Cass., 18 maggio 2025, n. 13192; Cass., 16 giugno 2025, n. 16178, n. 16166 e n. 16171, tutte decise in camera di consiglio il 18 marzo 2025).
4.1. In cinque delle sei ordinanze (Cass., 11 maggio 2025, n. 12477 e n. 12473; Cass., 16 giugno 2025, n. 16178, n. 16166 e n. 16171, in avanti richiamate unitariamente come “Giurisprudenza del caso superminimi”) la Cassazione interviene precisando, tra le altre cose, che l'uso aziendale: a) non è vincolante sine die ma può venire meno solo se disdettato dal datore di lavoro con una giustificazione formalizzata «mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della disdetta medesima diretta alla collettività dei lavoratori»; b) sopravvive, nel tempo, anche ai successivi rinnovi di CCNL perché non importa indagare la volontà del datore di lavoro di confermare la persistenza dell'uso esclusivamente con riferimento all'ultimo rinnovo fatto (e non anche a quello successivo). Su questo secondo punto le opposte argomentazioni vengono superate «alla luce della giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico e normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori».
4.2. In tutte le ordinanze viene ribadita l'esistenza di un orientamento pacifico (sul punto dell'irrilevanza dell'elemento volontaristico sono citate Cass., 8 aprile 2010, n. 8342, Cass., 22 marzo 2010, n. 5882; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489). Proprio per questa ragione, del resto, rimarcando che la questione non richiede alcun intervento nomofilattico, la Suprema Corte aveva rigettato la richiesta di trattazione pubblica avanzata dalla società cui aveva aderito la difesa dei lavoratori.
5. Sulla questione della forma della disdetta dell'uso aziendale segnalo che per la Cassazione «il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune” e che, di conseguenza, ciò sino ad oggi ha comportato che “la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi» (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3542). Sul punto, dunque, il principio affermato dalla Giurisprudenza del caso superminimi appare certamente interessante quanto innovativo.
6. Quanto alla seconda questione, relativa alla presunta irrilevanza dell'elemento volontaristico in materia di usi aziendali, invece, devo con qualche perplessità rilevare che, all'apposto delle pronunce che hanno riguardato il caso dei superminimi da cui ho preso spunto, per Cass., 13 gennaio 2025, n. 805 «questa Corte ha stabilito che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo; nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass., 20 maggio 2004, n. 9626; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489)».
6.1. Orbene, se per Cass., 13 gennaio 2025, n. 805 l'intento negoziale è essenziale, e oltretutto deve essere considerato alla luce della rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, per la successiva (di pochi mesi) Giurisprudenza del caso dei superminimi vale esattamente l'opposto e, quindi, l'uso deve essere apprezzato a prescindere dall'elemento volontaristico e senza alcun condizionamento della evoluzione dell'assetto normativo positivo.
6.2. Per completare il quadro segnalo che anche i precedenti richiamati dalla Giurisprudenza del caso dei superminimi non sono affatto univoci. Ciò in quanto mentre Cass., 8 aprile 2010, n. 8342 effettivamente si esprime negli stessi termini della Giurisprudenza del caso dei superminimi, per quanto attiene alle altre: Cass., 11 luglio 2007, n. 15489/2007 ribadisce chiaramente, all'opposto, che l'uso aziendale presuppone uno specifico intento negoziale che non può prescindere dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui si è manifestato; Cass., 22 marzo 2010, n. 5882, invece, non richiama affatto la questione della rilevanza o irrilevanza dell'elemento volontaristico nella formazione degli usi.
7. Potremmo commentare che stiamo evidenziando una fisiologica dialettica interna alla giurisprudenza della Suprema Corte e, quindi, potremmo con piacere lasciarci prendere dall'interesse intellettuale di indagare le tante sfumature nel tentativo di una ricostruzione sistematica della questione. Intanto, però, colpisce che il Collegio della Giurisprudenza del caso dei superminimi è composto per tre quinti dagli stessi magistrati che hanno pronunciato la sentenza, di segno opposto, di pochi mesi precedente (Cass., 13 gennaio 2025, n. 805).
È un sistema giuridico adeguatamente prevedibile? È una scelta o un incidente?